
Numero 9 del 2014
Medicina di genere
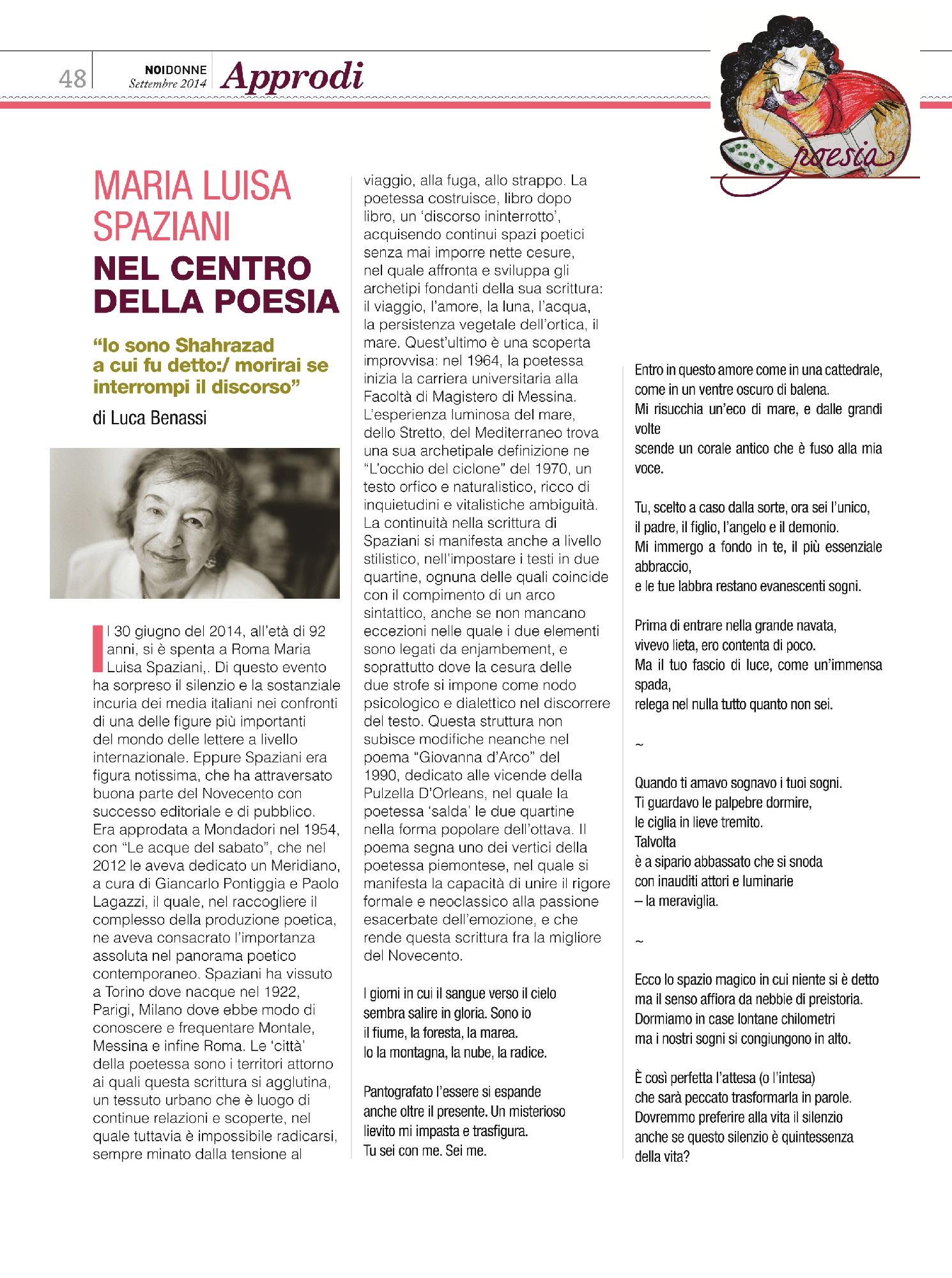
PAGINA 54
Cambia pagina:
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556
Testi pagina 54
48 Settembre 2014Il 30 giugno del 2014, all’età di 92 anni, si è spenta a Roma Maria Luisa Spaziani,. Di questo evento
ha sorpreso il silenzio e la sostanziale
incuria dei media italiani nei confronti
di una delle figure più importanti
del mondo delle lettere a livello
internazionale. Eppure Spaziani era
figura notissima, che ha attraversato
buona parte del Novecento con
successo editoriale e di pubblico.
Era approdata a Mondadori nel 1954,
con “Le acque del sabato”, che nel
2012 le aveva dedicato un Meridiano,
a cura di Giancarlo Pontiggia e Paolo
Lagazzi, il quale, nel raccogliere il
complesso della produzione poetica,
ne aveva consacrato l’importanza
assoluta nel panorama poetico
contemporaneo. Spaziani ha vissuto
a Torino dove nacque nel 1922,
Parigi, Milano dove ebbe modo di
conoscere e frequentare Montale,
Messina e infine Roma. Le ‘città’
della poetessa sono i territori attorno
ai quali questa scrittura si agglutina,
un tessuto urbano che è luogo di
continue relazioni e scoperte, nel
quale tuttavia è impossibile radicarsi,
sempre minato dalla tensione al
viaggio, alla fuga, allo strappo. La
poetessa costruisce, libro dopo
libro, un ‘discorso ininterrotto’,
acquisendo continui spazi poetici
senza mai imporre nette cesure,
nel quale affronta e sviluppa gli
archetipi fondanti della sua scrittura:
il viaggio, l’amore, la luna, l’acqua,
la persistenza vegetale dell’ortica, il
mare. Quest’ultimo è una scoperta
improvvisa: nel 1964, la poetessa
inizia la carriera universitaria alla
Facoltà di Magistero di Messina.
L’esperienza luminosa del mare,
dello Stretto, del Mediterraneo trova
una sua archetipale definizione ne
“L’occhio del ciclone” del 1970, un
testo orfico e naturalistico, ricco di
inquietudini e vitalistiche ambiguità.
La continuità nella scrittura di
Spaziani si manifesta anche a livello
stilistico, nell’impostare i testi in due
quartine, ognuna delle quali coincide
con il compimento di un arco
sintattico, anche se non mancano
eccezioni nelle quale i due elementi
sono legati da enjambement, e
soprattutto dove la cesura delle
due strofe si impone come nodo
psicologico e dialettico nel discorrere
del testo. Questa struttura non
subisce modifiche neanche nel
poema “Giovanna d’Arco” del
1990, dedicato alle vicende della
Pulzella D’Orleans, nel quale la
poetessa ‘salda’ le due quartine
nella forma popolare dell’ottava. Il
poema segna uno dei vertici della
poetessa piemontese, nel quale si
manifesta la capacità di unire il rigore
formale e neoclassico alla passione
esacerbate dell’emozione, e che
rende questa scrittura fra la migliore
del Novecento.
I giorni in cui il sangue verso il cielo
sembra salire in gloria. Sono io
il fiume, la foresta, la marea.
Io la montagna, la nube, la radice.
Pantografato l’essere si espande
anche oltre il presente. Un misterioso
lievito mi impasta e trasfigura.
Tu sei con me. Sei me.
MarIa LUISa
SPazIanI
Nel ceNtro
della poesia
“io sono shahrazad
a cui fu detto:/ morirai se
interrompi il discorso”
di Luca Benassi
Entro in questo amore come in una cattedrale,
come in un ventre oscuro di balena.
Mi risucchia un’eco di mare, e dalle grandi
volte
scende un corale antico che è fuso alla mia
voce.
Tu, scelto a caso dalla sorte, ora sei l’unico,
il padre, il figlio, l’angelo e il demonio.
Mi immergo a fondo in te, il più essenziale
abbraccio,
e le tue labbra restano evanescenti sogni.
Prima di entrare nella grande navata,
vivevo lieta, ero contenta di poco.
Ma il tuo fascio di luce, come un’immensa
spada,
relega nel nulla tutto quanto non sei.
~
Quando ti amavo sognavo i tuoi sogni.
Ti guardavo le palpebre dormire,
le ciglia in lieve tremito.
Talvolta
è a sipario abbassato che si snoda
con inauditi attori e luminarie
– la meraviglia.
~
Ecco lo spazio magico in cui niente si è detto
ma il senso affiora da nebbie di preistoria.
Dormiamo in case lontane chilometri
ma i nostri sogni si congiungono in alto.
È così perfetta l’attesa (o l’intesa)
che sarà peccato trasformarla in parole.
Dovremmo preferire alla vita il silenzio
anche se questo silenzio è quintessenza
della vita?
©2019 - NoiDonne - Iscrizione ROC n.33421 del 23 /09/ 2019 - P.IVA 00878931005
Privacy Policy - Cookie Policy | Creazione Siti Internet WebDimension®
Privacy Policy - Cookie Policy | Creazione Siti Internet WebDimension®